
Non dimentichiamola Nadia Toffa, non dimentichiamo ciò che lei ha fatto in vita, non permettiamo che tutto questo lavoro vada disperso. Con queste parole, don Maurizio Patriciello ha ricordato la giornalista scomparsa il 13 agosto 2019 a causa di un cancro. Da giorni, ovunque campeggia il suo nome accanto all'aggettivo ‘guerriera’, perché in molti hanno potuto assistere a quella che è sembrata a tutti gli effetti una dura battaglia sul campo. Non si vince e non si perde nella malattia, il senso di sconfitta presupporrebbe quasi che una persona non è stata abbastanza brava a fronteggiarla, ma combattere ogni giorno per rimanere in vita poi in fondo lo è una guerra.
‘Nadia era convinta di poterlo sconfiggere il cancro, che poteva guarire. Impossibile dirle di no’, ha dichiarato Max, uno degli autori de Le Iene, rafforzando il credo popolare sulla forza e la tenacia che le appartenevano per natura. La Toffa, giornalista sul campo con una cravatta nera al collo, pure ci credeva, e pure era forte e tenace e ostinata, tanto da addentrarsi nelle terre dei fuochi o in quelle dell’Ilva per dare voce a tutta quella gente che non si sentiva armata per combattere, che stava cedendo all’avanzare del tasso tumorale crescente e agli attacchi della noncuranza, che generava boati come palle di cannone.
Quella cravatta nera è stata posata sulla bara bianca e l’ha accompagnata nell’ultimo viaggio verso il cimitero. Non potrà più usarla, ma sarà sua per sempre. Funziona così quando sei una giornalista, quando la tua missione la senti ogni giorno nonostante te stessa. Le cose, le persone, i luoghi, ti appartengono anche quando non vorresti, anche quando saresti troppo stanca per guardarli e occupartene. La donna di Taranto che si è aggrappata alla sua bara è lo sguardo che si inverte, sono gli occhi che cambiano prospettiva e tentano di impedire il brusco arresto di uno scambio. Sia piaciuto o no il suo lavoro sul campo, è indubbio sia stato generato da una vocazione, la stessa che l’ha tenuta in vita dietro un bancone e non in strada, che le ha consentito di dare ossigeno a un corpo ormai abbrutito.
Davide Parenti, ‘papà’ televisivo di Nadia Toffa e de Le Iene, l’ha spiegato bene: "Il fatto che lavorasse l'ha tenuta in vita più di quanto la malattia le potesse permettere. È una malattia spietata. Quando ti dicono che hai quella cosa, in quel posto, e di quel tipo, basta che guardi su internet per leggere che hai al massimo dieci mesi. Lei ne ha fatti venti. Ovviamente sono stati bravissimi i suoi dottori, capaci di allungarle la vita con le giuste cure. Ma aver continuato a lavorare, avere un appuntamento cui tornare, un impegno con il pubblico, era per lei una delle ragioni per continuare a vivere".
E se c'è stato chi ha tentato ciclicamente di impedirle di continuare a vivere, con le sue domande insistenti e le critiche inopportune sul suo stato fisico e di salute, c'è stata un'enorme fetta di pubblico che ha alimentato questo processo di sopravvivenza, consentendole di tenersi stretta la sua ‘divisa' per non vestire i panni della malata. Non è l'abito scuro, non è una cravatta e nemmeno un microfono ad aver fatto di Nadia Toffa una giornalista, era il non esserselo mai chiesto, fino alla fine, se quel lavoro aveva meritato tutto un tempo di vita che, all'improvviso, è diventato solo un breve passaggio sulla Terra.

;Resize,width=369;)
;Resize,width=369;)
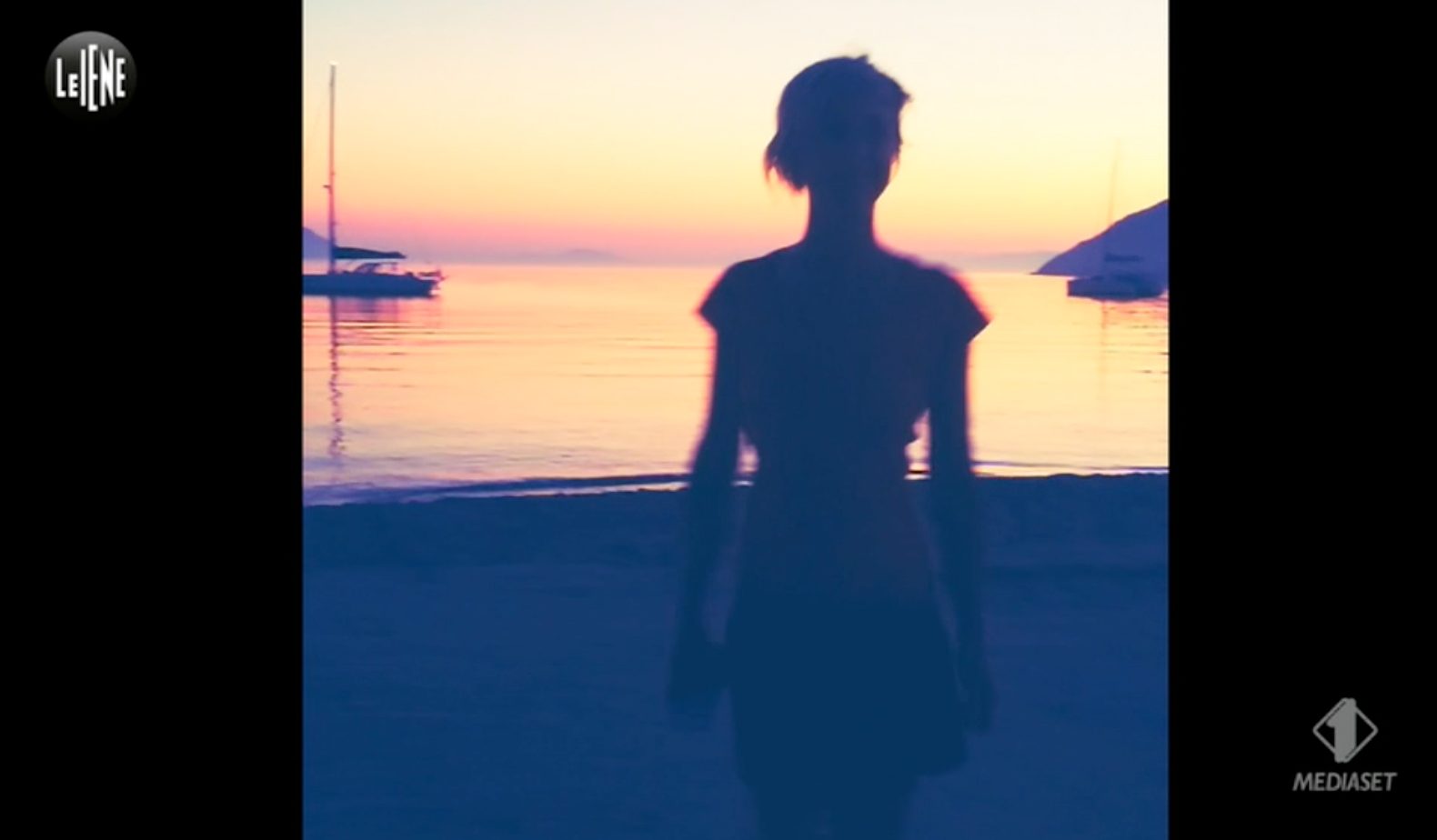;Resize,width=369;)

